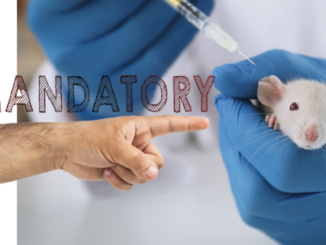La recente decisione dell’Unione Europea di prorogare l’autorizzazione all’uso del glifosato per altri dieci anni, pur introducendo nuove restrizioni, ha riacceso il dibattito sulla sicurezza di questo erbicida. Al centro della discussione si è collocata, in parte, la visibilità data agli studi condotti dall’Istituto Ramazzini, che – utilizzando modelli animali, in particolare ratti – avrebbero fornito evidenze del potenziale cancerogeno della sostanza.
Tuttavia, è opportuno chiarire alcuni punti essenziali. Esistono già dati epidemiologici sull’uomo che suggeriscono un’associazione tra esposizione al glifosato e l’insorgenza di linfomi non-Hodgkin. Al contempo, la comunità scientifica internazionale – inclusi NIH, FDA e Commissione Europea – riconosce oggi la necessità di un cambiamento metodologico profondo nella valutazione della tossicità e nella ricerca biomedica, superando modelli sperimentali ormai sempre più ampiamente riconosciuti come inadeguati.
Evidenze epidemiologiche: segnali da non ignorare
Negli ultimi due decenni, numerosi studi epidemiologici hanno investigato la relazione tra l’esposizione al glifosato e l’incidenza di neoplasie linfatiche. Alcuni studi caso-controllo e metanalisi (es. Zhang et al., 2019, Leon et al., 2019) indicano un’associazione positiva tra esposizione professionale al glifosato e aumento del rischio di linfoma non-Hodgkin. Altri studi, tra cui il ben noto Agricultural Health Study (AHS), non riportano un’associazione statisticamente significativa.
Questa eterogeneità nei risultati riflette i limiti metodologici insiti nell’epidemiologia ambientale: misclassificazione dell’esposizione, confondenti non controllati, eterogeneità dei contesti di utilizzo.
Mentre la IARC (Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro) ha classificato il glifosato come “probabile cancerogeno per l’uomo”, l’EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) ha invece concluso che è improbabile che la sostanza rappresenti un rischio cancerogeno per la salute umana.
Tuttavia, la presenza di un segnale epidemiologico ricorrente giustifica la necessità di studi sperimentali orientati a chiarire i meccanismi d’azione alla base delle osservazioni cliniche.
Vi sono poi diversi studi sia epidemiologici che in vitro che riportano associazione con disturbi dermatologici, neurotossicità, irritazioni acute e croniche tra lavoratori agricoli esposti, che non possono essere ignorati.
Modelli animali: limiti metodologici, inaffidabilità
La conferma sperimentale dei dati osservazionali è un passaggio scientificamente necessario. Tuttavia, affidarsi ai modelli animali tradizionali -come ha fatto il Ramazzini – per questo scopo solleva interrogativi metodologici e regolatori rilevanti. Le differenze interspecifiche in termini di metabolismo, risposta immunitaria, farmacodinamica e fisiologia rendono scarsamente traslabili all’uomo i risultati ottenuti in roditori.
Gli studi condotti su ratti, come quelli dell’Istituto Ramazzini, non possono essere considerati “prova forte”. Al contrario, la comunità tossicologica discute da anni la bassa affidabilità predittiva, la scarsa riproducibilità e il rischio di falsi positivi o negativi legati a questi modelli. In un contesto regolatorio moderno, si tratta di dati che possono essere facilmente smentiti man mano che la scienza chiarisce i meccanismi attraverso modelli più evoluti.
Il riconoscimento istituzionale del cambio di paradigma
Questa transizione non è solo auspicabile: è già formalmente riconosciuta da organismi scientifici e regolatori. NIH e FDA hanno pubblicato documenti strategici che indicano la necessità di sviluppare metodologie alternative alla sperimentazione animale per aumentare la rilevanza clinica delle valutazioni tossicologiche. La Commissione Europea, con la sua Roadmap 2023 per la transizione ai metodi non animali, ha avviato un processo sistemico per la sostituzione progressiva degli animali nei test regolatori, promuovendo approcci human-relevant.
Modelli in vitro tradizionali: un altro collo di bottiglia
Anche i test in vitro tradizionali come monocolture statiche e bidimensionali mostrano limiti analoghi. Queste colture cellulari, anche se human-based, non replicano la complessità fisiologica dei tessuti umani, né permettono lo studio di interazioni sistemiche, risposte immunitarie o effetti cronici. Utili per screening iniziali, non sono sufficienti per trarre conclusioni regolatorie o comprendere pienamente la tossicità sistemica del glifosato.
NAM: verso una tossicologia human-relevant
I New Approach Methodologies (NAMs), offrono oggi una prospettiva scientificamente solida per affrontare la valutazione del rischio in modo più predittivo e affidabile. Questi approcci comprendono:
- Modelli 3D avanzati, come organoidi e organ-on-chip;
- Tecnologie omiche (transcrittomica, proteomica, metabolomica) per l’identificazione di pathways avversi (AOP);
- Modelli computazionali (in silico) per simulare esposizioni e meccanismi d’azione;
- Biomonitoraggio umano, integrato con dati ambientali e sanitari real-world.
L’adozione integrata di questi strumenti consente una valutazione realistica e sistemica del rischio, centrata sull’uomo, eticamente sostenibile e metodologicamente più robusta rispetto ai modelli ereditati dal Novecento. Noi di OSA ci auspichiamo che gli isituti di ricerca più moderni e prestigiosi, come il Ramazzini, siano tra i primi in Italia ad abbracciare l’innovazione.
Le aule di giustizia riconoscono ciò che la scienza tarda ad accettare
Mentre la ricerca scientifica continua a dibattere sul valore degli studi epidemiologici e sulla necessità di conferme meccanicistiche dei dati, i tribunali statunitensi si sono già espressi con decisione. Negli ultimi anni, decine di giurie popolari hanno esaminato in dettaglio le prove disponibili – tra cui dati epidemiologici, testimonianze di esperti, documenti interni delle aziende – e hanno stabilito in più casi un nesso plausibile tra l’esposizione prolungata a glifosato e l’insorgenza di linfomi non-Hodgkin.
Sono oltre 100.000 le cause legali intentate contro Monsanto (ora Bayer) negli Stati Uniti. Questi procedimenti hanno portato a risarcimenti per oltre 11 miliardi di dollari, con sentenze che riconoscono una responsabilità aziendale per mancata comunicazione dei rischi e negligenza grave (AP News, 2025a; Reuters, 2025). Si tratta di decisioni fondate su mesi di udienze, durante le quali la prova scientifica è stata sottoposta a vaglio pubblico, legale e multidisciplinare.
Il fatto che i tribunali civili statunitensi – per loro natura cauti nel riconoscere responsabilità sanitarie – abbiano accolto in modo ricorrente il nesso tra esposizione e danno rafforza la credibilità del segnale epidemiologico. Non si tratta di aneddoti isolati, ma di un corpus decisionale che ha già inciso profondamente nella giurisprudenza della responsabilità civile in campo ambientale e sanitario.
Conclusioni
I dati disponibili sull’uomo suggeriscono che il glifosato rappresenta un rischio reale per la salute. Di fronte a questi segnali, è doveroso approfondire per portare delle prove causali definitive, ma con strumenti adeguati ed affidabili.
Continuare a investire nella sperimentazione animale, nonostante il riconoscimento istituzionale dei suoi limiti, rappresenta un ostacolo al progresso scientifico e regolatorio. Le istituzioni più autorevoli concordano: serve un cambio di paradigma. È tempo di spostare il baricentro della tossicologia su modelli rilevanti per la biologia umana.
Non si tratta di “vietare il glifosato perché lo dicono i ratti”, ma nemmeno di ignorare i segnali epidemiologici. Si tratta di confermare – o eventualmente smentire – questi segnali con gli strumenti giusti, al servizio di una scienza più solida e di una regolamentazione più responsabile.
Fonti principali
- Zhang, L., Rana, I., Shaffer, R. M., Taioli, E., & Sheppard, L. (2019). Exposure to glyphosate-based herbicides and risk for non-Hodgkin lymphoma: A meta-analysis and supporting evidence. Mutation Research, 781, 186–206. https://doi.org/10.1016/j.mrrev.2019.02.001
- Leon, M. E., Schinasi, L. H., Lebailly, P., Beane Freeman, L. E., Nordby, K. C., Ferro, G., … & Kjaerheim, K. (2019). Pesticide use and risk of non-Hodgkin lymphoid malignancies in agricultural cohorts. International Journal of Epidemiology, 48(5), 1519–1535. https://doi.org/10.1093/ije/dyz017
- AP News. (2025a). Weedkiller maker asks US Supreme Court to block lawsuits claiming it failed to warn about cancer. https://apnews.com/article/monsanto-supreme-court-weedkiller-lawsuit-2025
- AP News. (2025b). Georgia jury orders Monsanto parent to pay nearly $2.1 billion in Roundup weedkiller lawsuit. https://apnews.com/article/monsanto-roundup-verdict-georgia-2025
- Reuters. (2025). Bayer’s Monsanto loses appeal of $611M Roundup verdict in Missouri. https://www.reuters.com/legal/bayers-monsanto-loses-appeal-611m-roundup-verdict-missouri-2025
- European Commission. (2025). Roadmap towards phasing out animal testing in chemical safety assessments. https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/chemicals/reach/roadmap-towards-phasing-out-animal-testing_en
- U.S. Food and Drug Administration (FDA). (2025). FDA announces plan to phase out animal testing requirement for monoclonal antibodies and other drugs. https://www.fda.gov/news-events/press-announcements/fda-announces-plan-phase-out-animal-testing-requirement-monoclonal-antibodies-and-other-drugs
- National Institutes of Health (NIH). (2023). NIH to prioritize human-based research technologies. https://www.nih.gov/news-events/news-releases/nih-prioritize-human-based-research-technologies
- Rivas-García, T., Espinosa-Calderón, A., Hernández-Vázquez, B., & Schwentesius-Rindermann, R. (2022). Overview of Environmental and Health Effects Related to Glyphosate Usage. Sustainability, 14(11), 6868. https://doi.org/10.3390/su14116868
- National Institutes of Health. (2025b). Agricultural Health Study (AHS). Retrieved from https://aghealth.nih.gov/